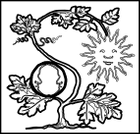di Giulia Paradisi
L’agorafobia è definita come “la paura di ritrovarsi in piazze, luoghi deserti o eccessivamente affollati, dove il soggetto ritiene di non poter ricevere aiuto in caso di improvviso malessere” (Westphal, 1871).
L’Agorafobia è sicuramente il disturbo fobico più grave e disabilitante, presenta bassi indici di remissione spontanea, e si riscontra in circa un 50% di soggetti che soffre di disturbo di panico (Wittchen et al., 2008; Wittchen et al., 2010), normalmente si sviluppa come conseguenza di tale disturbo (Ballenger e Fyer, 1996) e ciò avviene solitamente entro un anno dall’esordio degli attacchi di panico (APA, 2014).
E’ un disturbo d’ansia che, ogni anno, viene diagnosticato a circa l’1,7% di adolescenti e adulti, con un doppio di possibilità delle donne di soffrirne rispetto agli uomini. Il picco di incidenza si ha nella tarda adolescenza e nella prima età adulta, anche se può verificarsi, in una percentuale minore di casi, anche in età infantile.
Come si manifesta?
Lo stato emotivo che caratterizza questo disturbo è la paura o l’ansia, relative ad alcune situazioni:
-trovarsi in spazi aperti (es. parcheggi, mercati, ponti, piazze);
-trovarsi in spazi chiusi (es. negozi, teatri, cinema) e/o connotati da caratteristiche di “costrizione” (es. stare in fila, tra la folla, sui mezzi pubblici);
-la solitudine, in particolare quando l’individuo si trova lontano da casa.
Il timore del soggetto, come accennato precedentemente, è legato al fatto che potrebbe essere difficile fuggire oppure che potrebbe non essere disponibile soccorso nell’eventualità che si sviluppino sintomi simili al panico o altri sintomi invalidanti o imbarazzanti (es. paura di cadere, dell’incontinenza).
Il soggetto che ne soffre generalmente tende ad evitare la situazione o richiede la presenza di un accompagnatore; nel caso in cui non sia possibile evitare o farsi accompagnare, sopporta con paura o ansia molto intense.
La paura o l’ansia sono: sproporzionate rispetto al reale pericolo posto dalla situazione agorafobica (e spesso l’individuo sa di essere “eccessivamente” preoccupato, e valuta come “strani” i suoi comportamenti e le sue paure), causano disagio significativo o compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti, sono persistenti e durano tipicamente sei mesi o più (American Psychiatric Association, 2014).
Cosa fa il soggetto di fronte alla situazione che teme?
Spesso richiede la presenza di un compagno affidabile, con il quale si sente più sicuro, meno spaventato. E’, come succede per tutti i disturbi d’ansia, un quadro che si può complicare, anche a causa della messa in atto di comportamenti di evitamento che procurano un sollievo immediato ma un danno a medio e lungo termine (pensiamo alla riduzione degli investimenti di vita che il soggetto si ritrova a fare nell’arco di tempo in cui il disturbo, magari non trattato, prende campo). L’evitamento delle situazioni può compromettere, a lungo andare, la capacità di recarsi al lavoro o di portare avanti le semplici e consuete incombenze domestiche. Nella sua forma più grave, infine, l’agorafobia può rendere gli individui costretti in casa, incapaci di uscire e dipendenti dagli altri.
Ma quali sono le condizioni che facilitano l’insorgenza del panico negli individui con agorafobia?
La solitudine, la costrizione e gli spazi aperti e vasti.
La ragione di questo va ricercata nel minimo comune denominatore di queste tre condizioni e, nello specifico, nella catastrofe temuta dagli agorafobici.
Quello che l’individuo affetto da agorafobia teme è la perdita di controllo, percepita come dissolvimento del senso di sé, come perdita della coscienza di sé e della percezione di sé come agente, come individuo in grado di autodeterminarsi e di prendere decisione autonome. Questo timore sarebbe alla base dei timori di morte e di impazzimento riportate dai soggetti con disturbo di panico. E’ come se l’individuo si dicesse “Non sono più io a comandare me stesso, non ho più il controllo su di me”. L’impazzimento viene temuto ed immaginato come la trasformazione in una sorta di “zombie”, con aspetti di perdita di agentività e di potere decisionale sulle proprie azioni (Gragnani e Mancini, 2004, 2008).
Vediamo nello specifico le tre condizioni sopra accennate e, nello specifico, quali sono le caratteristiche di tali condizioni che innescano il panico nei soggetti agorafobici.
La solitudine. Questa condizione è caratterizzata dall’assenza o dall’indisponibilità di figure di riferimento, significative per il soggetto. La loro assenza provoca nell’individuo agorafobico sensazioni di indebolimento del senso di sé. L’effetto rassicurante dell’accompagnatore “di fiducia”, deriva dalla funzione di riconoscimento reciproco e di rispecchiamento con un altro familiare. L’aspetto particolarmente temuto della solitudine è quindi l’assenza di familiarità, e non l’assenza di protezione.
- Valeria ha 20 anni, è una studentessa universitaria. Comincia a soffrire di attacchi di panico con agorafobia dopo essersi trasferita nella città universitaria, dove non conosce nessuno e si sente particolarmente sola e spaesata. La paura si intensifica nel momento in cui, la sera, si ritrova nella sua camera e pensa alle persone che ha lasciato a casa. In particolare le manca tanto la madre, con la quale ha da sempre un rapporto «speciale».
Con lei mi confidavo, era l’unica che sapeva tutto di me. Ora senza di lei mi sento vuota, spaesata, mi sembra di non riconoscermi più!
La costrizione. Le situazioni costrittive sono valutate dall’agorafobico in termini di diminuzione della possibilità di esercitare la propria volontà ed agentività (Gragnani e Mancini, 2008). Con questo termine si fa riferimento sia alle situazioni fisicamente costrittive (es. stare ad un concerto stracolmo di persone, o in fila alla posta all’ora di punta), sia quelle “psicologicamente” tali, in cui ad esempio il potere è nelle mani dell’altro (come nel caso dell’aereo, in cui è il pilota a comandare il mezzo). Anche in questo caso il soggetto si focalizza su aspetti di riduzione della possibilità di esercitare la propria agentività e della capacità di autogestione.
- Luca ha 35 anni, è un libero professionista. Da anni evita di salire su mezzi pubblici. Per affrontare i viaggi per lavoro in treno assume farmaci ansiolitici. Descrive come insopportabile l’idea di salire sulla metro, su un autobus o su un treno, dove, nel caso in cui avesse un malore, teme di non poter uscire immediatamente e di rimanere così a lungo all’interno da rischiare la vita.
Là dentro mi sento impotente, mi sento subito mancare il respiro e il cuore va a mille! E’ come se a bordo la mia vita non dipendesse da me e questa cosa è terribile!
Gli spazi aperti. Sono temuti per l’assenza di punti di riferimento di tipo percettivo (pensiamo ad una grande piazza dove, per centinaia di metri, non abbiamo nulla): questo facilità la comparsa di sensazioni di disorientamento, che l’agorafobico percepisce come minacciosi in termini di disgregazione del senso di sé.
- Sandra ha 42 anni, è una casalinga. Ogni volta che deve attraversare una piazza o un ponte comincia ad escogitare mentalmente dei percorsi alternativi, per la paura che prova alla sola idea di farlo da sola. Quando non può fare altrimenti, richiede insistentemente la presenza del marito o della sorella, le uniche persone di cui dice di fidarsi.
Ogni volta che mi avvicino ad una piazza e sono sola mi sento svenire, mi gira la testa, spesso mi appoggio ai muri dei palazzi ma questo è imbarazzante. Solo se accanto a me ci sono Simone o Laura allora mi sento più forte e ho il coraggio di attraversarla!
Dal prima al dopo
Il soggetto agorafobico, prima di entrare nel disturbo, si percepiva come una persona forte e autonoma, capace di cavarsela da sola; dopo la comparsa e con l’aggravarsi dei sintomi spesso si vede e si definisce eccessivamente debole e spaventato da tutto. Questo può comportare una ripercussione negativa in termini di autostima (“prima mi piacevo, mi sentivo un leone, poi da un giorno all’altro sono diventato una pecora”).
Spesso questo cambiamento può essere vissuto con abbattimento, demoralizzazione, fino a volte a portare ad una vera e propria depressione. Ad aggravare questo stato d’animo c’è talvolta la constatazione, da parte del soggetto, di essere maggiormente debole e dipendente dagli altri, di aver ridotto gli investimenti di vita, di sentirsi meno efficace e meno attivo, il che può comportare un’ulteriore abbattimento. Non è infrequente che tale stato d’animo porti la persona a cercare strategie di automedicazione del tutto inappropriate (come abuso di alcol o di farmaci sedativi), che non fanno altro che peggiorare il disturbo stesso, facilitando la comparsa di quelle sensazioni di inconsistenza che vengono poi interpretate dall’individuo stesso come segnale di allarme.
Eventi precipitanti il disturbo
Spesso, prima del manifestarsi del disturbo vero e proprio, sono capitati nella storia della persona degli eventi che hanno contribuito all’insorgere della sofferenza. Quali possono essere?
La perdita affettiva. Sono quegli eventi che implicano una perdita non tanto di protezione, di vicinanza o di attaccamento, quanto piuttosto di criteri identificanti, che riguardano il chi sono io (talvolta, ad esempio, vengono riportate separazioni da persone verso le quali il soggetto svolgeva mansioni di accudimento o di sostegno).
Oppure mutamenti di incarico lavorativo (non necessariamente licenziamenti o eventi generalmente considerati traumatici), oppure variazioni naturali nel ciclo di vita ma implicanti una modificazione di ruolo (ad es. il passaggio da “studente” a “lavoratore”).
- Elena ha 39 anni, è una dipendente aziendale. Da persona forte e autonoma si ritrova ad essere dipendente dagli altri e costantemente in ansia, cosa che non le era mai successa prima. Questo cambiamento avviene in concomitanza ad una promozione sul lavoro che aveva fortemente desiderato, per la quale si sente da una parte entusiasta ma dall’altra molto spaventata. Ciò che la preoccupa di più è che non si riconosce in questo nuovo ruolo.
Non riesco a riconoscermi in questa veste, ho perso tutti i miei punti di riferimento e questa novità mi terrorizza!
Il restringimento di un legame. Si fa riferimento al restringimento di una relazione che presuppone l’indebolimento o l’interruzione di un altro legame identificante, ad esempio con la famiglia di origine (es. il matrimonio, in cui passo dal ruolo di figlio al ruolo di coniuge).
Oppure quelle situazioni in cui la persona percepisce un aumento delle proprie responsabilità e fronteggia questo evento con una richiesta di un maggiore autocontrollo e di presenza a se stesso (come nel caso della nascita di un figlio).
O, ancora, situazioni nelle quali la persona si vede nelle mani dell’altro (riduzione della propria agentività), giungendo a sopportare progressivamente sempre meno quella categoria di sensazioni che attengono all’indebolimento o alla fluttuazione del senso di sé.
- Fabio ha 41 anni, è disoccupato. Diventa padre in concomitanza con un licenziamento sul lavoro inaspettato. Si ritrova in casa per molte ore al giorno e la sua unica occupazione è quella di accudire il figlio. Comincia a soffrire di attacchi di panico ed agorafobia e si ritrova, anche quando vorrebbe farlo, ad evitare di uscire anche per andare a fare la spesa, per paura di un nuovo attacco.
Non sopporto più l’idea di dovermi occupare solo di mio figlio! Mi sento in colpa a dirlo, ma mi sento in gabbia! E’ solo che tutto pesa su di me e non posso non aiutare mia moglie, che è l’unica che lavora!
Perché sono più vulnerabile di un altro?
I fattori di vulnerabilità, cioè quelle variabili che predispongono un soggetto più di un altro ad andare incontro ad un disturbo agorafobico, riguardano alcune credenze o autoimposizioni che si sono strutturate nel corso della propria storia di vita.
- Sono psichicamente fragile!
La credenza di essere una persona psichicamente fragile, può svilupparsi in soggetti che percepiscono la fragilità psicologica familiare reale o presunta (spesso è presente un disturbo mentale) e se ne attribuiscono le caratteristiche come se fossero geneticamente trasmissibili. Non di rado si tratta di sistemi familiari molto rigidi che fanno un uso massiccio dell’ipercontrollo.
- Devo assolutamente evitare la perdita di controllo!
si riscontra spesso in storie di bambini che assistono ad importanti perdite del controllo da parte di un genitore (ad es., perché ubriaco, arrabbiato o per gravi disturbi mentali) magari con conseguenze gravi o comunque impressionanti; o che si assumono la responsabilità dei genitori (in quanto non in grado o non disposti ad accudire) e che dunque, per esperienza appresa, ritengono indispensabile essere sempre ben presenti a se stessi, o, bambini che hanno subito squalifiche (invalidazioni) o rifiuti quando esprimevano segni di vulnerabilità, di bisogno e di dipendenza.
- Certe sensazioni sono il sintomo di una perdita di controllo definitiva ed irreparabile!
E’ di frequente riscontro in persone che hanno realmente sviluppato una vulnerabilità psicologica per una serie di motivi, come l’aver assistito frequentemente a reazioni d’allarme da parte dei genitori di fronte alle sue reazioni ed attivazioni emotive con espliciti commenti preoccupanti, o semplicemente non aver ricevuto spiegazioni da parte degli adulti di riferimento circa le cause di tali reazioni.
- Incapacità di gestire momenti in cui il senso di sé fisiologicamente si riduce
In questo ultimo caso possono aver giocato un ruolo decisivo dei sistemi ipercontrollanti che tendono a ridurre drasticamente (o totalmente) le esperienze di solitudine, e dunque le occasioni per apprendere la gestione di momenti di allentamento del senso di sé, oppure un atteggiamento genitoriale negligente e disattento ai vissuti del figlio, che non di rado si accompagna ad ineducazione psicologica e quindi si traduce anche nell’assenza di esperienze di aiuto e normalizzazione nella gestione di questi momenti (Gragnani, Paradisi & Mancini, 2011).
La terapia
La strategia terapeutica che viene privilegiata nell’ambito del nostro indirizzo teorico e che comprende un insieme di tecniche specifiche, si pone primariamente l’obiettivo di promuovere l’accettazione della sensazione dell’indebolimento del senso di sé, considerata dal paziente minacciosa e assolutamente da scongiurare. Brevemente, le fasi che costituiscono il cuore dell’intervento:
1° FASE: promozione dell’accettazione della sensazione di indebolimento del senso di sé.
2° FASE: psicoeducativa. Presentazione didattica del disturbo, materiale cartaceo (libri, articoli) che riguarda definizioni dell’ansia, del panico e dell’agorafobia.
3° FASE: accettazione del danno temuto. Scopo di favorire un atteggiamento meno prudenziale e quindi, per il soggetto stesso, meno costoso in termini di sofferenza percepita.
Si lavora sul legame tra determinate sensazioni e il timore associato ad esse, inducendo il soggetto a non prevenire tali sensazioni, ma disponendosi a viverle qualora si presentino.
4° FASE: Esposizione. Lo scopo è quello di aumentare la disposizione a tollerare quelle sensazioni di fluttuazione del senso di sé, imparando a considerarle come delle condizioni passeggere e non pericolose. L’esposizione può essere di due tipi:
Enterocettiva: si confrontano le sensazioni indotte da esercizi fisici con quelle causate dall’ansia e dal panico al fine di modificare le credenze e le interpretazioni erronee che generalmente le accompagnano.
In vivo: si chiede al paziente di esporsi alla situazione temuta senza mettere in atto quei comportamenti protettivi e gli evitamenti ai quali solitamente ricorre (“prevenzione della risposta”).
5° FASE: Prevenzione delle ricadute. Si valutano se e quali aspetti della storia e della personalità del paziente possano predisporlo a ricadute e quali aspetti debbano essere modificati per potenziare la capacità di affrontare eventuali situazioni critiche senza ulteriori scompensi.
In coda all’articolo, due video che mostrano i sintomi di un soggetto con disturbo di panico con agorafobia e i vari tentativi di fronteggiare la propria paura (tratti dal film Copycat – Omicidi in serie, un film di Jon Amiel del 1995).
La protagonista del film, una psicologa criminale, soffre di una grave forma di agorafobia e si ritrova a vivere dentro la sua casa per il timore di esporsi a tutte le situazioni che teme. Nel primo video si vede il tentativo di fuga non riuscito dalla propria abitazione, nella quale si è introdotto un serial killer. Nel secondo video si vede la protagonista intenta a mettere in atto un tentativo di recupero di una rivista che le è stata depositata a qualche metro dal portone di casa, per evitare di varcare la soglia tanto temuta.
Per saperne di più sull’argomento
Ballenger, J.C., & Fyer, A.J. (1996). Panic Disorder and Agoraphobia. In T.A. Widiger, A.J. Frances, H.A. Pincus, R. Ross, M.B. First, e W.W. Davis (Eds) DSM IV sourcebook, vol 2 (pp.411-471). American Psychiatric Association, Washington, DC
American Psychiatric Association (2014). Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Quinta edizione. DSM-5. Milano: Raffaello Cortina
Gragnani, A., & Mancini F. (2004). L’indebolimento del senso di sé e la sindrome Agorafobica. XII Congresso Nazionale SITCC “L’evoluzione del cognitivismo clinico: I modelli, i metodi, la ricerca”. Verona
Gragnani, A., & Mancini, F. (2008). Il Disturbo di Panico e l’Agorafobia. In C. Perdighe, e F. Mancini (Eds.), Elementi di Psicoterapia Cognitiva (pp 85-108). Roma: Fioriti Ed. s.r.l.
Gragnani, Paradisi & Mancini, 2011
Gragnani, A., Paradisi, G., Mancini, F. (2011). Un modello cognitivo del Disturbo di Panico e dell’Agorafobia: aspetti psicopatologici e linee di intervento. Psicobiettivo, n.3, 2011, Franco Angeli
Westphal (1871) CO. Die Agoraphobie: eine neuropathische Erscheinung. Arch Psychiatr Nervenkr
Wittchen, H.U., Nocon, A., Beesdo, K., et al. (2008). Agoraphobia and panic: prospective-longitudinal relations suggest a rethinking of diagnostic concepts. Psychotherapy and Psychosomatics; 77:147–157