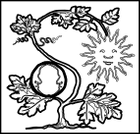di
Pamela Calussi
Noi tutti conosciamo l’importanza delle emozioni: fin da piccoli impariamo che sono loro a guidarci, impariamo a riconoscerle, comunicarle, esprimerle in modo corretto.
Secondo Castelfranchi, un’emozione è uno stato soggettivo complesso che comprende vissuti personali, aspetti fisiologici, motivazionali ed espressivi, e “sorveglia” i nostri scopi: in altre parole, ci aiuta controllare il raggiungimento di scopi che hanno per noi un alto valore; proviamo un’emozione, più o meno intesa, quando ciò che ci sta succedendo può provocare il raggiungimento o la compromissione di uno scopo molto importante per il nostro benessere o addirittura per la nostra sopravvivenza. Le emozioni e gli scopi sono strettamente legati: oltre ad informarci sul raggiungimento o meno di un nostro scopo in modo immediato, le emozioni hanno anche la funzione di attivarli, scatenando una spinta all’azione che ci porta verso l’obiettivo desiderato.
Possono essere positive o negative, a seconda che ci aiutino o meno al raggiungimento dei nostri scopi.
Le emozioni possono anche diventare esse stesse scopi: possiamo fare qualcosa o non fare qualcosa allo scopo di provare o meno una certa emozione: per esempio, posso decidere di percorrere una strada per incontrare una persona e provare gioia.
Le emozioni sono tutte utili, e tutte hanno una loro funzione: la paura ci protegge dai pericoli, il disgusto ci protegge dalle intossicazioni, la rabbia ci protegge dal poter subire un danno, un’ingiustizia, che possa compromettere il raggiungimento di uno status desiderato.
E la tristezza, quell’emozione che spesso cerchiamo di nascondere, o reprimere, a cosa serve?
“Io sono Tristezza, e ho voluto bene a Riley fin dall’inizio, l’ho aiutata a piangere quando era appena nata. Era importante che piangesse in quel momento. Aveva appena fatto capolino nel mondo, un mondo grande e sconosciuto. E lei era così piccola e affamata, aveva freddo e voleva stare al calduccio. Allora si è messa a piangere e ha ottenuto ciò che desiderava” (Tristezza, Inside Out).
Uno dei grandi meriti del famoso cartone animato della Disney Pixar, Inside Out, è proprio questo: ci ha aiutato a capire l’importanza di essere tristi.
Essere tristi, e mostrare agli altri la nostra tristezza, senza reprimerla, senza nasconderla, ha la funzione di comunicare agli altri che qualcosa non va: il pianto del bambino, appena nato, ci comunica che ha bisogno di qualcosa, è una richiesta di aiuto, e attiva il nostro comportamento nel tentativo di soddisfare questa richiesta. Come suggerisce Bowlby, infatti, nel bambino piccolo il pianto è una sorta di sistema di allarme, che lui attiva per comunicare all’altro (alla mamma) che ha bisogno di qualcosa; è una forma di azione sul mondo esterno, qualcosa che produce un effetto (desiderato). Noi tutti siamo biologicamente programmati per rispondere al pianto: corriamo, cerchiamo soluzioni.
La tristezza, inoltre, segnala a noi e agli altri la perdita o la compromissione di uno scopo importante, e ha la funzione in qualche modo di poter recuperare le energie per poter recuperare (se possibile) quello scopo o investire su un altro raggiungibile.
“Gioia gli si avvicinò per consolarlo, -Andrà tutto bene, ok? Risolveremo ogni cosa! (…)- Gioia non si rendeva conto che era inutile cercare di farlo ridere: Bing Bong era triste perché aveva perso qualcosa di importante. Aveva bisogno di essere triste. Così mi sedetti al suo fianco (…) fu allora che cominciò a piangere, lasciai che mi appoggiasse la testa sulle spalle -Lo so, è triste- dissi, e continuai a tenerlo stretto finché le lacrime cessarono e Bing Bong sollevò il capo e si asciugò gli occhi. -Sto bene ora!- e cominciò a camminare. Gioia mi guardava con espressione confusa -Come ci sei riuscita?-, -Non lo so, Lui era triste e io l’ho ascoltato-”. (Tristezza, Inside out).
In questa bellissima scena di Inside out, Bing Bong, un amico immaginario della protagonista, ha perso un suo scopo importante (andare sulla luna con Riley, cosa che non può più fare perché ha perso il suo carretto a propulsione canora), ed è disperato, perché lo scopo è irrecuperabile (dalla discarica nulla torna indietro). Gioia cerca di distrarlo, di non farlo pensare a ciò che ha perso, ma di farlo pensare a ciò che deve fare, ma questo non lo consola: ha bisogno di piangere, ha bisogno di disperarsi, ha bisogno di stare dentro la sua disperazione per poterla capire e per pianificare quello che deve fare, e, una volta fatto, una volta “elaborato” il lutto, è pronto a ripartire, perché il pianto è stato funzionale al ripristino di una condizione di benessere: ha ridotto la tensione e lo stress, e ha
aiutato a spostare l’attenzione su nuovi obiettivi.
“Quando penso a quello che mi è accaduto mi sento precipitare in un abisso di disperazione…ed è così confortante..” (Tristezza, Inside out)
Ma c’è molto di più: ne ha parlato, qualcuno lo ha ascoltato, qualcuno lo ha capito, qualcuno ha accettato il suo dolore, lo ha accolto, e lo ha normalizzato: piangere è normale, soprattutto se i succede una cosa così brutta.
Spesso (se non sempre) invece siamo portati a bloccare il pianto, a fermarlo, proprio come tenta di fare Gioia con Bing Bong: diciamo ai nostri figli “Non piangere per il ginocchio sbucciato, passerà tutto!” “Non piangere, non serve a niente, la prossima volta prenderai un bel voto!”. Crediamo quindi che reprimere il pianto equivalga a reprimere il disagio stesso: ma non è così, stiamo solo “soffocando” l’espressione esterna del disagio, ma di certo non risolviamo il problema. Perché per noi è così difficile accettare il pianto? Non è forse normale che nostro figlio pianga se cade o se prende un brutto voto? Non è forse normale piangere se perdiamo qualcuno di caro?
Accettare il pianto non è un semplice “Aspetto che passi”, ma consolare, abbracciare, condividere,
dare attenzioni, aiutare chi ci sta mostrando tristezza a esprimere il disagio e comunicarci un suo bisogno. Ascoltare. Quando per esempio lasciamo il nostro bambino con un estraneo (per esempio, l’inserimento al nido), è normale che il bambino pianga: la teoria dell’attaccamento di Bowlby, infatti, ci dice che questo è indice di un attaccamento sicuro, ovvero, se il bambino sta bene con la mamma è assolutamente normale che pianga e si disperi se essa va via. Il pianto, oltre a comunicare alla mamma che lui è triste che lei se ne vada, serve al bambino a esprimere la sua frustrazione e a capirla, per poi orientarsi verso una soluzione (es. gioco con i bambini). Quasi sempre, invece, per esempio nei giorni di inserimento al nido, le mamme se ne vanno disperate se lasciano il bambino in lacrime, pensando di fare una cosa terribile (“Lo sto abbandonando!”) e trascinandosi dietro il loro (grosso) senso di colpa.. Ma non è così, perché il pianto è si doloroso da tollerare, ma non è dannoso: ci serve per calmarci, e anche se, di fatto non risolve la situazione (la mamma di certo non lascerà il lavoro perché il bambino piange), ma aiuta a esprimere ciò che prova.
Aiutare un bambino a esprimere correttamente le proprie emozioni anziché ad inibirle, lo aiuta a diventare un adulto consapevole del proprio stato emotivo, in grado di regolarle e accettarle.
L’assenza di pianto, inoltre, non necessariamente indica uno stato di benessere o l’assenza di malessere: potrebbe anche significare che il bambino ha imparato a reprimere le proprie emozioni, perché sa che in qualche modo è inutile esprimerle (“se cado, mia mamma non mi abbraccerà, ma verrò sgridato perché non sono stato abbastanza attento”), e quindi inutile chiedere aiuto.
Cosa ci impedisce di accettare davvero la tristezza?
La tristezza dell’altro ci segnala il suo malessere, e questo a sua volta ci fa soffrire, per due motivi: perché ci segnala che qualcosa non va, e perché pensiamo che stiamo sbagliando qualcosa o che non possiamo aiutarlo (potremmo fare di più per aiutarlo o ci sentiamo impotenti) o che abbiamo sbagliato qualcosa (“Potevo evitare che si sentisse triste? Ho sbagliato qualcosa?”).
È normale e naturale cercare di prevenire o eliminare le emozioni negative di coloro ai quali vogliamo bene, ma spesso i tentativi di soluzione sono volti a eliminare quelle sgradevoli sensazioni che sentiamo noi di riflesso, e hanno la conseguenza di reprimerle o allontanarle, senza averle elaborate.
La grande verità che Inside Out ci insegna è questa: che non può esistere gioia senza tristezza: se riusciamo a riconoscerla ed accettarla si può trasformare in una spinta all’adattamento o al cambiamento alle situazioni nuove; solo quando Riley riesce a comunicare ai genitori il suo disagio per i numerosi cambiamenti ai quali è stata esposta, la situazione prende una piega positiva, e riesce ad adattarsi alla nuova vita. Il disastro era avvenuto prima: quando c’era stato il tentativo di voler essere felici a tutti i costi, di voler cercare di non pensare a ciò che di bello aveva perso e proiettarsi subito al futuro. Ma ignorava il presente, che era fatto di tristezza, di cose care e sicure che non c’erano più, ad uno status emotivo e sociale perso per sempre. Solo quando ha accettato il presente, Riley è stata meglio, e si è concessa di essere triste, di stare male, piangere e disperarsi: ha, in altre parole, smesso di negare le emozioni negative.
“Piangere mi tranquillizza, mi fissa sulla gravità dei problemi della vita” (Tristezza, Inside out).
Tutti vogliamo essere felici, quando siamo felici, cerchiamo di tenerci stretta questa sensazione e ci sforziamo di allontanare ogni sensazione di infelicità.
In realtà, sono proprio questi sforzi ad impedirci di essere felici: se riuscissimo ad accettare tutto ciò che ci capita nella vita, compreso il dolore, riusciremo a vivere più sereni.
Bibliografia
Castelfranchi C, Mancini F, Miceli M (2002). Fondamenti di cognitivismo clinico. Bollati Boringhieri. Torino
Castelfranchi C. (2005). Che figura. Ed. Il Mulino. Bologna
Disney Pixar (2015). Emozioni. Cinque storie raccontate dalla mente. Giunti ed.
Perdighe, C. (2015). Il linguaggio del cuore. Riconoscere e accettare le emozioni dei propri figli e accompagnarli nella crescita. Erickson ed.